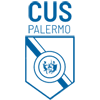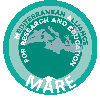3. Testa dell’Athena Lemnia
Lodatissima per la bellezza del viso dagli autori antichi, alcuni dei quali si spinsero a definirla la creazione più ammirabile del suo artefice (Pausania, Periegesi I, 28, 2; Luciano, Immagini 4), l’Athena Lemnia fu commissionata a Fidia dai coloni ateniesi della cleruchia di Lemno e dedicata sull’Acropoli, presso i Propilei, all’inizio della seconda metà del V secolo a.C. Il suo volto fu riconosciuto da Adolf Furtwängler, per mezzo di una delle sue più celebri (e discusse) identificazioni, in una testa di Bologna proveniente dalla collezione del pittore Pelagio Palagi, la quale costituisce senza dubbio il più bell’esemplare, forse risalente all’età augustea, di una tradizione copistica attestata solo da pochi pezzi giunti fino a noi. Si tratta di una testa in marmo priva degli occhi, che dovevano essere lavorati a parte in altro materiale e inseriti nelle cavità orbitali. Alcuni dettagli dell’esecuzione, come la notevole incisività con cui sono rese le ciocche di capelli trattenuti da una tenia, in particolare sulla fronte, riecheggiano forse la superficie del bronzo originale. Il pezzo era destinato a una statua lavorata a parti staccate, come denota la conformazione particolare del dado di base, funzionale all’inserimento della testa nel tronco corporeo.
Basandosi anche su due torsi conservati a Dresda, Furtwängler propose una ricostruzione dell’originaria immagine fidiaca come una figura stante, appoggiata alla lancia stretta nella mano sinistra e con la testa chinata a guardare l’elmo, tenuto nella destra. Nell’esattezza della sua interpretazione egli confidava a tal punto, che volle porla al principio della sua grande trattazione dei capolavori della scultura greca (Meisterwerke der griechischen Plastik,Leipzig-Berlin 1893). Nonostante molte voci discordanti, sia contemporanee all’archeologo tedesco sia più recenti, l’identificazione da lui sostenuta è tuttora perlopiù accettata.
Calco in scala 1:1. Come in molti altri casi, sulla superficie del gesso si riconoscono le bave lasciate dalla lavorazione per tasselli.
Inventario: SA 511.
Misure: cm 46 x 29 ca.
Bibliografia: S. Rambaldi, La Gipsoteca del Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo. Storia e Catalogo, Palermo, Palermo University Press, 2017 (“Artes”, n.s. 2), pp. 40-41, nr. 4 (con bibliografia di riferimento sull’originale).