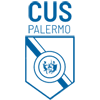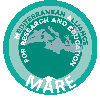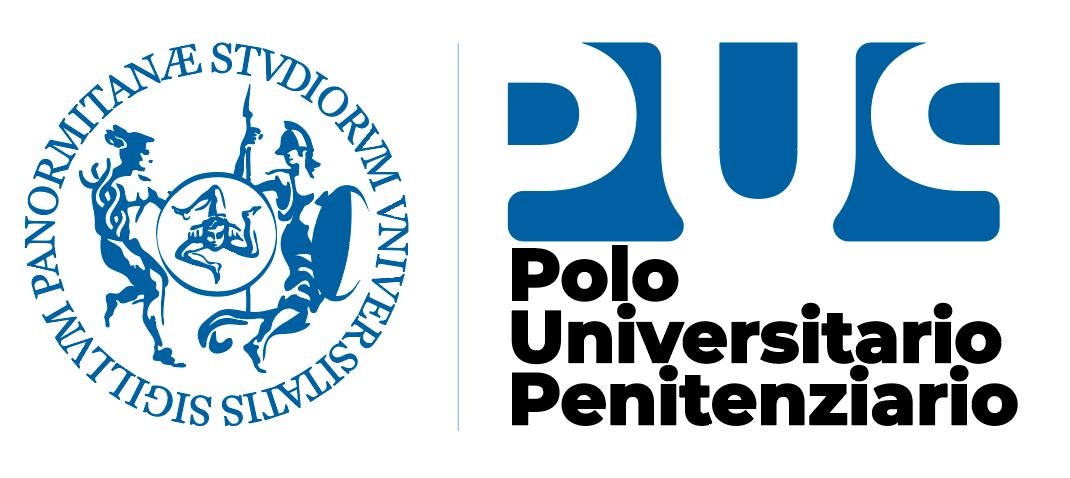16. Niobe e figlia
Il mito racconta che Niobe era a tal punto orgogliosa della propria prolificità da ritenersi superiore a Latona, poiché questa aveva generato soltanto Apollo e Artemide. Per castigare la superbia della donna, i due dèi decisero di colpirla proprio in ciò che aveva più caro, trafiggendo a colpi di freccia tutti i suoi figli, i quattordici Niobidi (sette maschi e sette femmine, ma il numero è diverso in alcune fonti). Il tragico episodio fu rappresentato plasticamente mediante un grande gruppo scultoreo, i cui componenti sono ricostruibili sulla base di diversi cicli parziali di repliche, di cui il più celebre e completo è quello, proveniente dall’Esquilino, che è conservato in una sala ad esso appositamente dedicata nella Galleria degli Uffizi. L’acceso patetismo, manifestato soprattutto dal volto della Niobe di Firenze, la quale costituiva certamente il fulcro dell’intero complesso, aveva suggerito in passato il nome di Skopas come possibile autore del gruppo originale, ma la concezione di questo sembra meglio riconducibile al filone classicistico di età tardoellenistica. Una datazione non posteriore alla prima età antonina è invece sostenibile, su base stilistica, per la redazione delle repliche fiorentine.
Il gesso riproduce l’immagine di Niobe, rappresentata nel vano sforzo di proteggere, traendola a sé, la figlia minore, la quale nel grembo della madre cerca scampo dalle frecce di Artemide (a lei spettava l’uccisione delle figlie femmine, mentre Apollo si era riservato quella dei maschi). La giovinetta, la cui piccola figura appare seminuda, poiché la sua veste si è abbassata nell’agitazione della fuga, si stringe contro il corpo della donna, che si piega sopra di lei. Niobe, abbigliata con un chitone e un mantello, solleva un lembo di quest’ultimo per tentare di riparare la figlia dall’ira divina. Essendo frutto di un’integrazione, in passato erano stati espressi dubbi sulla correttezza del gesto compiuto dal braccio sinistro, anche sulla base del confronto con una statuetta cretese che mostra l’arto abbassato. Ma il recente rinvenimento di una replica frammentaria dello stesso gruppo della Niobe tipo Uffizi, nella zona del grande ninfeo nella Villa dei Quintili sulla via Appia Antica a Roma, ha permesso di confermare la sostanziale validità del restauro mediceo.
Il calco, in scala molto ridotta, riproduce esattamente l’iconografia dell’originale fiorentino, comprese le parti di restauro. La base risulta invece un poco più bassa. L’immagine di Niobe è priva dell’avambraccio sinistro con l’estremità del mantello stretta nella mano, nonché della porzione inferiore della gamba destra avvolta dalle pieghe del chitone. Questo pezzo e il nr. 17 si differenziano dagli altri calchi della collezione a causa del materiale di cui risultano composti, una miscela di colore rossastro, simile alla terracotta, che in alcuni punti affiora dalla scialbatura superficiale. Qua e là emergono le capocchie di alcuni chiodini in ferro, dello stesso tipo di quelli visibili sul Cinghiale nr. 24.
Inventario: probabilmente uno dei pezzi catalogati GA 420-428 (si veda il capitolo sulla storia della Gipsoteca).
Misure: cm 59,5 x 24.
Bibliografia: S. Rambaldi, La Gipsoteca del Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo. Storia e Catalogo, Palermo, Palermo University Press, 2017 (“Artes”, n.s. 2), pp. 64-65, nr. 16 (con bibliografia di riferimento sull’originale).